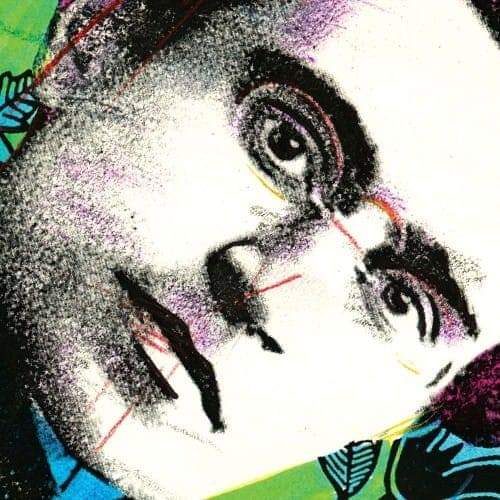di STEFANO BOMBACI, in antudo.info
Da più parti si sente riparlare di “questione meridionale”, ma ha ancora senso parlarne e se ne ha è possibile parlarne senza legarla alla “questione dei territori”? Del resto persino Gramsci, che in sostanza sposava la lettura degli economisti liberali per quanto atteneva l’origine della “questione meridionale”, aveva intuito a suo modo che la questione andava ben oltre le problematiche particolari del meridione d’italia e ancora nel 1923 scriveva «la quistione meridionale è anche quistione territoriale ed è da questo punto di vista – scriveva Gramsci – che deve essere esaminata per stabilire un programma di governo operaio e contadino che voglia trovare larga ripercussione nelle masse».
Alle origini della “questione meridionale” c’è una precisa e diffusa lettura del sud Italia e delle isole che le descrive dominate, ancora nel secolo XIX, da sistemi economici, politici e culturali largamente feudali e precapitalistici. Questa condizione di arretratezza rispetto allo sviluppo capitalistico degli stati preunitari del nord Italia sarà ritenuta la radice della “questione meridionale” nell’Italia divenuta unita.
Non saranno solo gli economisti liberali del secolo XIX a sostenere questa interpretazione, Gramsci stesso così come Grieco e i comunisti dell’epoca accolgono questa tesi che in definitiva era coerente con lo “sviluppo per stadi” delle società propria di un certo marxismo ed in particolar modo propagandata da Engels.
Ruggero Grieco nel 1926 in un documento di partito che voleva rendere operative le tesi di Lione nel mezzogiorno, scriveva:
«I tentativi delle monarchie meridionali di opporre alla proprietà feudale la piccola proprietà andarono del tutto falliti, nel nuovo regime politico-giuridico del XIX secolo la grande proprietà continuò a prevalere conservando quasi ovunque immutati i caratteri della proprietà feudale […] l’assenza di un largo strato di borghesia commerciale ed industriale e il carattere feudale della borghesia terriera costituirono uno dei fattori predominanti della vita sociale nel mezzogiorno» (Ruggero Grieco, Scritti scelti, vol. I, Roma 1966, p. 89)
E dieci anni prima Gramsci su «Il grido del popolo» osservava: «Da una parte [il Nord Italia] la tradizione di una certa autonomia aveva creato una borghesia audace e piena di iniziative, ed esisteva una organizzazione economica simile a quella degli altri Stati d’Europa, propizia allo svolgersi ulteriore del capitalismo e dell’industria. Nell’altra [il Sud Italia] le paterne amministrazioni di Spagna e dei Borboni nulla avevano creato: la borghesia non esisteva, l’agricoltura era primitiva e non bastava neppure a soddisfare il mercato locale; non strade, non porti, non utilizzazione delle poche acque che la regione, per la sua speciale conformazione geologica, possedeva. L’unificazione pose in intimo contatto le due parti della penisola».
Questa lettura, pressoché univoca e sostanzialmente falsa, una lettura che testimoniava una estrema superficialità di analisi e che non teneva nemmeno conto delle testimonianze degli economisti meridionali del ‘700, dura di fatto sino alla metà del ‘900, quando si riconoscerà da parte degli intellettuali di sinistra l’avvenuta integrazione strutturale del meridione nel capitalismo italiano e quindi si riterranno ormai fuori tempo le analisi di Gramsci e del meridionalista Grieco. La questione meridionale diventa ora una questione di scelte politiche effettuate dallo Stato unitario.
Assistiamo quindi ad un passaggio: la “questione meridionale” passa da questione strutturale di persistenza di modi di produzione diversi e diversi modi di accumulazione della ricchezza a una questione di “ritardo” nello sviluppo. Un ritardo dovuto a precise scelte di politica economica da parte dello stato unitario (Zitara parlerà senza mezzi termini di scelta coloniale). Le problematiche affrontate dai meridionalisti di conseguenza si centreranno sulle cause e sul modo in cui avvenne l’unità/annessione e sulle misure politiche ed economiche per colmare il gap nord/sud che saranno poi drammaticamente legate alle politiche di crescita industriale per il meridione e per le isole.
Due visioni diverse della “questione meridionale” che tuttavia in qualche modo, direttamente o indirettamente, hanno dei punti in comune. Qui se ne elencano tre:
1. Non è il capitalismo la causa dello stato economico, politico e culturale del meridione, ma i retaggi feudali che ne ostacolano lo sviluppo. In altre parole la causa è la mancanza di capitalismo;
2. Che promuovere lo sviluppo capitalistico del sud è condizione indispensabile per eliminare gli squilibri esistenti;
3. che gli squilibri provocati dalle scelte dello Stato Unitario si risolvono comunque nell’ambito delle strutture esistenti attraverso i meccanismi di mercato – secondo i liberali – o con politiche di riforme perequative (intervento dello Stato) – secondo i marxisti italiani dell’epoca.
Naturalmente c’è stato chi intorno alla “questione meridionale” si è mosso in tutt’altra direzione sostenendo la natura puramente ideologica della tesi del “sottosviluppo originario del sud” e individuando la “costruzione” del sottosviluppo delle regioni meridionali e delle isole nella politica economica del nuovo Stato Italiano tra il 1861 e gli anni protezionismo del 1887. Questi autori sostenevano che in prima istanza è il capitalismo a creare disfunzioni nelle aree controllate dal suo mercato; che particolarità del capitalismo è il suo sviluppo ineguale (quindi produzioni, scambi, modalità di consumo, culture ecc. ineguali) e che il sottosviluppo di alcuni territori, così come lo sviluppo di altri, è funzione particolare ed essenziale delle formazioni sociali capitalistiche. Di conseguenza se lo sviluppo ineguale e quindi il sottosviluppo del sud è stato ed è condizione essenziale del capitalismo italiano è “eliminabile solo con esso”, come hanno sostenuto Edmondo Capecelatro e Antonio Carlo in Per la critica al sottosviluppo meridionale.
Per quanto mi riguarda propendo per questa seconda visione che mette l’accento su un aspetto fondamentale del funzionamento del sistema capitalistico: lo sviluppo ineguale come carattere proprio dello sviluppo capitalistico e quindi l’impensabilità di una sua soluzione – e cioè di uno sviluppo omogeneo – all’interno del sistema capitalistico stesso.
Cosa significa sviluppo ineguale? Che il processo di sviluppo capitalistico è un processo discontinuo e squilibrante nel quale si producono continuamente diseguaglianze. Un processo per nulla lineare, sostanzialmente incoerente, di flussi ineguali e di diversa intensità, a territorializzazione variabile e alternanza delle procedure di estorsione di plusvalore assoluto e relativo. Un insieme di processi che costruiscono un mondo altamente conflittuale attraversato dai modelli di sviluppo che – di volta in volta, area per area, situazione per situazione – riescono meglio ad articolare le sempre più risicate condizioni di valorizzazione del capitale. Un processo antico, certo, ma che nell’epoca della crisi strutturale dello sviluppo capitalistico accentua a dismisura le sue diseguaglianze temporali e geografiche, disuguaglianze che hanno concreti e traumatici risvolti sociali.
Samir Amin, nel suo libro Lo sviluppo ineguale del 1973, sostiene che «lo sviluppo del capitalismo è ovunque sviluppo delle ineguaglianze regionali. Così ogni paese sviluppato ha creato nel proprio seno il suo paese sottosviluppato: ne è un esempio la metà meridionale dell’Italia» (p.392).
Ora come è noto il 1973 è l’anno della cosiddetta “crisi petrolifera”, in verità una crisi di sistema, che chiudeva gli anni dell’espansione economica e che dava avvio a un mastodontico processo di ristrutturazione politica ed economica. L’anno dopo, nel 1974, c’è il primo G6 (che riuniva i sei paesi più industrializzati del mondo: USA, Giappone, Francia, Germania, GB e Italia), ossia il tentativo di voler concordare misure economiche e politiche che riequilibrassero le contraddizioni derivanti dalla crisi dei mercati sempre più interdipendenti tra di loro e che rilanciassero il processo di accumulazione capitalista. In breve va consolidandosi la necessità di costruire aree economiche strutturate. Ancora una modificazione, quindi, degli assetti “geografici” del capitalismo. Di fatto si assiste ad un nuova fase di quella che oggi chiamiamo globalizzazione: flessibilità produttiva, robotizzazione e informatizzazione, delocalizzazione, sottomissione reale delle aree di produzione delle materie prime, riduzione pianificata del valore della merce forza-lavoro. Un processo di ristrutturazione economica che è nel medesimo tempo un processo di ristrutturazione politica. Gli Stati Nazione, infatti, andranno progressivamente adeguandosi alla nuova configurazione regionale. Inizia, insomma, quel processo di revisione della forma Stato in cui ancora oggi ci troviamo. Finisce l’era dello stato assistenziale e si inizia a fare i conti con le necessità legate alla riduzione delle spese, alla flessibilizzazione del mercato della forza lavoro, alla demolizione delle acquisizioni sindacali e per far questo occorre riformare gli istituti della decisione in un vorticoso processo di emarginazione delle funzioni legislative del parlamento in favore dell’esecutivo tramite, ad esempio, il ricorso ad un uso spregiudicato dei decreti legge.
Non si tratta, vale la pena di sottolinearlo, di processi lineari, ma di un processo discontinuo che fa i conti con la conflittualità sociale oltre che, naturalmente, con gli interessi contrastanti tra frazioni dei diversi gruppi che controllano l’economia e, cosa assolutamente non secondaria, che si trova a fare i conti con le nuove configurazioni spaziali che assume il capitale nel suo complesso e quindi con quelle che David Harvey chiama le “dinamiche geografiche dell’accumulazione capitalista”. Tuttavia è un processo inesorabile: la trasformazione del modello produttivo si accompagna con la trasformazione dello Stato, del suo carattere e delle sue funzioni.
Trasformazione dello Stato, tuttavia, non significa tendenza alla sua scomparsa, ma che le sue funzioni (istituzionali, sociali ed economiche) non sono più quelle che conoscevamo. Nella nuova geografia disegnata dall’Unione Europea, ad esempio, lo Stato va mutando concretamente nei suoi elementi costitutivi come quello di sovranità e di territorialità, pur continuando ad assolvere funzioni strategiche nella riproduzione della materia sociale, prima fra tutte quelle di controllo e di dominio.
Un controllo ed un dominio sociale che interiorizzano le ragioni dei gruppi economici dominanti, ne interpretano i bisogni e le strategie e realizzano le condizioni politiche, giuridiche ed ideologiche che ne garantiscono gli interessi.
Si tratta di uno Stato che deve transitare un modello di sviluppo divenuto ipertrofico ad un altro modello di sviluppo che possa rilanciare l’accumulazione massimizzando i profitti, e in questo transito esso stesso, lo Stato, trasforma le sue funzioni. Si tratta di una trasformazione come detto non lineare, che si muove per emergenze e che utilizza l’emergenza come deroga ai limiti del vecchio Stato di diritto liberale.
Si tratta certamente di una transizione ancora in atto, non ancora conclusa, che si muove tra spinte alla centralizzazione di alcune sue funzioni e spinte alla decentralizzazione o meglio alla costituzione di una rete policentrica dello sviluppo di cui lo Stato si fa controllore e garante. Forse l’attuale proposta di “regionalismo differenziato” va proprio in questo senso.
Certo è che si sta già definendo una geografia particolare, diversa da quella tratteggiata dai “meridionalisti” con la polarizzazione NORD italia-SUD italia, ma con la creazione di tanti “NORD” e tanti “SUD”, una geografia dello sviluppo e del sottosviluppo, di aree ad elevato sviluppo e delle aree depresse o come scrivono alcuni tecnici senza pudore delle “aree sotto-utilizzate” e questa dizione la dice lunga sulla filosofia che informa lo Stato contemporaneo e il capitale in crisi strutturale.
Per essere più precisi: le “aree sottoutilizzate” dette anche “aree depresse” non sono solamente, secondo i criteri adottati dall’Europa e dal Ministero dello Sviluppo, il meridione d’Italia e le isole, ma la costellazione di territori o di “aree censuarie” con la percentuale di PIL inferiore al 75% della media comunitaria. Per “zona censuaria” si intendono i territori uniformi per caratteristiche economiche, sociali o ambientali.
I dati riportano circa 3.700 “aree sottoutilizzate” o “depresse” nel Centro-Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise) a cui naturalmente si aggiungono le regioni del meridione che rientrano tutte “per intero” nella definizione di aree depresse (Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia).
Naturalmente rimane la sproporzione tra i territori meridionali, per intero depressi rispetto alle media europea, e quelli settentrionali dove le aree depresse si presentano a macchie di leopardo. Eppure se vogliamo inquadrare il problema in modo non ideologico dobbiamo riflettere sul fatto che le questioni legate allo sviluppo ineguale non riguardano soltanto i territori meridionali (e quindi non si tratta soltanto di “questione meridionale”), ma riguardano la questione del dominio sui territori, su tutti i territori, e in particolare riguardano i territori periferici rispetto ai “nodi” della rete policentrica del nuovo modello di sviluppo.
Un altro esempio indicativo è “La mappa dell’Italia da connettere”: si tratta dei piani degli operatori privati 2014-2016 che riguardano le prime 500 città italiane: “quelle più popolose e redditizie”. La mappa raccoglie i dati forniti dal Ministero dello Sviluppo economico nell’ambito del Piano strategico per la banda ultra larga. Commenta «il Sole 24 ore»: «In quelle aree la domanda di connettività è piuttosto interessante perché vi abitano circa 27,5 milioni di persone, risiedono 2,5 milioni di imprese (una ogni undici abitanti ovvero 65 per chilometro quadro) e 40 mila sedi della PA che potranno sfruttare tutti i nuovi servizi digitali. Pensiamo, per esempio alle scuole e agli ospedali. Non sorprende che gli operatori vogliano concentrarsi su queste zone. Ne deriva che il piano con i fondi pubblici si dovrà occupare di tutte le altre».
Questa “geografia particolare” è quella che sta disegnando il nuovo modello di sviluppo da più parti definito predatorio o “estrattivista”, come scrivono alcuni autori. In verità non si tratta di qualcosa di mai visto, di qualcosa di nuovo, quel che c’è di nuovo è che questo modello acquista una nuova centralità rispetto al modello dell’organizzazione fordista (basata sulla rigidità dei fattori produttivi per la produzione di massa e quindi sulla fabbrica). La centralità assunta dal nuovo modello ad un tempo contiene ed oltrepassa la contraddizione Capitale-Lavoro, che nel modello “fordista” manteneva un ruolo centrale, creandone una più estesa e radicale: quella tra Capitale e territori. Con Capitale qui ci si riferisce al sistema capitalistico in quanto “modo di produzione e dominio” ossia alla congiunzione costitutiva di Stato e capitale.
Per meglio comprendere la nuova strategia del capitale sui territori si riportano di seguito alcuni passi da un testo del 2015 di “didattica” per gli imprenditori delle piccole e medie imprese, “Dal capitalismo molecolare alla learning organization”:
«La catena di produzione del valore è diventata quindi più complessa e si è allargata sul territorio. È diventata una ragnatela di produzione del valore… L’efficienza di un territorio, delle sue infrastrutture, dei suoi servizi, delle sue stesse relazioni sociali (la fiducia tra gli attori, le competenze disponibili a livello locale), nei sistemi distrettuali è diventata un importantissimo fattore di produzione, alla stessa stregua del capitale e del lavoro. Il territorio è l’ambiente strategico dove l’impresa seleziona le risorse che le servono per competere sia interne che esterne al ciclo produttivo».
Per il nuovo modello di sviluppo i territori sono ambienti strategici che se trasformati in nodi della rete producono “valore aggiunto alle reti globali”. Come si diventa “nodi della rete”?
Si tratta di circostanze sviluppate all’interno dei territori come “tranquillità sociale” (ossia assenza di conflittualità, disponibilità sindacale, efficacia delle forze e dei mezzi di polizia ed una extralegalità controllata), disponibilità di “forza lavoro istruita”, servizi, adeguate infrastrutture (buona rete viaria, prossimità alle aeree portuali ed aeroportuali). In questo contesto le amministrazioni comunali, i partiti e le cosiddette “autonomie funzionali” (fondazioni bancarie, ASL, camere di commercio, ecc.) giocano un ruolo strategico nelle capacità di promozione, negoziazione, predisposizione del territorio alla competitività attesa ed è in questo senso che vanno progressivamente trasformandosi.
Tutti i territori, anche quelli che mai potranno diventare effettivi “nodi della rete”, tendono ad essere rimodellati in questa logica. Si uniformano ai criteri generali dell’urbanizzazione contemporanea, sono costretti dagli “eventi” a scimmiottare le metropoli perdendo irrimediabilmente la storia della loro stessa produzione. I territori sono predisposti a partire da ciò che per essi e che da essi ci si attende in produzione di valore. Spremuti come limoni e abbandonati quando la produzione di valore cessa. Il territorio è pensato, piegato ed agito unicamente come spazio della circolazione, distribuzione e produzione; deve divenire nel suo complesso fattore economico ed in quanto tale deve essere “liberato” da ogni residuo del passato modello di sviluppo (un esempio è la progressiva scomparsa dei piccoli esercizi commerciali o delle attività artigianali incalzati dalla GDO o come nel caso delle produzioni agricole la scomparsa della piccola proprietà). Di più, il territorio deve essere liberato dal tessuto relazionale che lo ha prodotto storicamente, da ogni organizzazione delle relazioni sociali che lo irrigidiscono non permettendone la necessaria flessibilità e va liberato dalle insorgenze sociali che contestano e resistono alla sua trasformazione.
Il territorio è trattato come merce e come ogni altra merce ha valore in quanto valore di scambio: acqua, terra e cielo, pace sociale, forza lavoro a basso costo, amministrazioni ben disposte, sicurezza e adatte infrastrutture contro investimenti e cioè occupazione/lavoro.
A questo punto è bene fare alcune precisazioni sul concetto per nulla astratto di territorio. Innanzitutto, come del resto ha ben capito la nuova economia, il concetto di territorio non equivale a quello di spazio, ma un insieme vivo di relazioni che “lo sviluppo” vuole adeguare ai suoi propri fini.
Per Magnaghi il territorio è “un organismo vivente ad alta complessità, un neo-ecosistema in continua trasformazione”. Si tratta di una costruzione storico-culturale di lunga durata, è patrimonio assolutamente non riducibile a risorsa economica. Un patrimonio particolare che si esprime nella relazione esistente tra componente umana e ambientale. Il territorio si dà nell’insieme delle relazioni di una comunità consapevole del “valore patrimoniale dei beni comuni territoriali che rimangono essenziali per la riproduzione della vita individuale e collettiva, biologica e culturale” scrive Magnaghi.
Ora la preda è proprio questo patrimonio, che viene attaccato dal nuovo modello di sviluppo, strappato ai suoi abitanti e ridotto a risorsa per accumulare profitti.
Il conflitto sociale che ne scaturisce è quindi di tipo nuovo e più complesso, rispetto a quello vissuto nel XX secolo. Ed è più complesso perché abbraccia nel medesimo tempo la vita di ognuno di noi in tutte le sue articolazioni (nel lavoro, nelle relazioni interpersonali, nei conflitti tra le classi, negli ambienti urbani ed extraurbani, ecc.).
Il conflitto sociale che si presenta scaturisce quindi dall’insieme esplosivo delle contraddizioni scatenate dalla crisi strutturale del sistema capitalistico. È conflitto col suo dominio. È un conflitto tra “eterodirezione e istanze locali di autonomia e di autogoverno”.
Sembra ormai chiaro che gli elementi che contraddistinguono l’insorgenza di questo nuovo conflitto siano caratterizzati dalla critica e dal rifiuto di un triplice sfruttamento: del proprio lavoro, della propria vita e della propria terra, in una parola del proprio abitare.
La situazione di insostenibilità in cui si trovano i territori meridionali, che pressoché per intero sono posti fuori dalla rete dei nodi di sviluppo, è la situazione da cui partiamo perché è qui che ci troviamo.
L’insostenibilità prodotta dalla distruzione dei contesti dell’abitare ci spinge con forza alla ricerca di una nuova sostenibilità: 1. sostenibilità politica, sta nella capacità di costruire l’autogoverno delle comunità locali; 2. sostenibilità sociale, sta nella capacità di integrare nei meccanismi della decisione l’intera comunità territoriale; 3. sostenibilità economica, sta nella capacità di costruire gli elementi di una nuova economia fuori dalle logiche del profitto e strutturata sulle reali esigenze delle comunità territoriali; 4. sostenibilità ambientale, ossia la capacità di avviare processi produttivi compatibili con l’ecosistema.
Ritornando al quesito iniziale, “questione meridionale o questione dei territori?”, la risposta non può che essere: la questione meridionale oggi è la questione dei territori. Se, insomma, non si riesce ad articolare la “questione meridionale” con la “questione dei territori” si corre il rischio di non comprendere il progetto su cui muove il nuovo modello di sviluppo e quindi di non attrezzarsi degli strumenti politici indispensabili per cambiare rotta.
*Intervento al ciclo di seminari “Mezzogiorno di Fuoco: ripensare la questione meridionale e la retorica del sottosviluppo”, organizzato da Fajdda – unione giovanile indipendentista e Centro Zabùt.