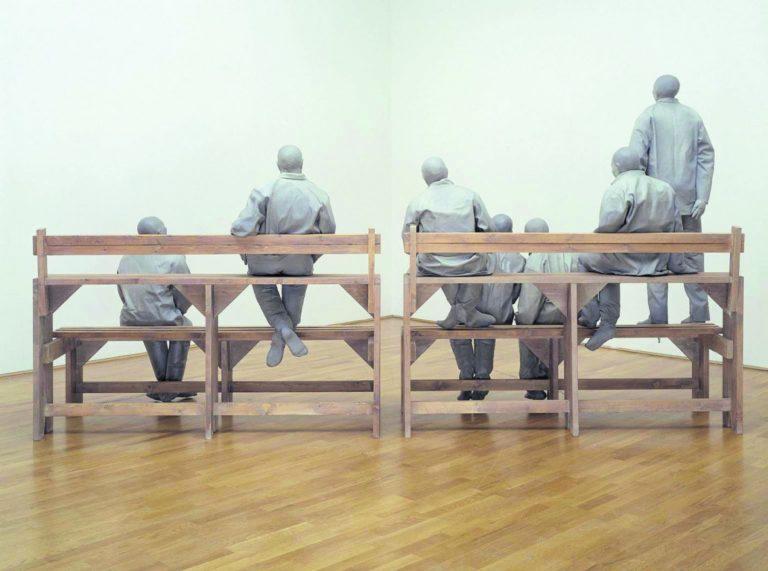di SERGIO BOLOGNA (in Deriveapprodi.org)
Testo dell’intervento di Sergio Bologna alla presentazione del numero speciale di “Primo maggio” che si è tenuta a Torino sabato 1 dicembre nella sala delle conferenze del Polo del ’900 a cura dell’Archivio Cinematografico Nazionale della Resistenza in collaborazione con l’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “G. Agosti”.
Quando inizia la letteratura sul “declino” in Italia?
Sarebbe interessante fare una ricerca ad hoc, perché – se non ricordo male – non è stata una qualche corrente “riformista” ad iniziare questo percorso, sono stati ambienti culturali contigui a Confindustria. Un percorso che poi si è incamminato su un terreno dove il tema del “declino” è diventato quasi mainstream al punto da condizionare lo sguardo all’indietro (come dimostra l’Annale Feltrinelli dello scorso anno intitolato l’Approdo mancato). Senza riuscire a temperare tuttavia lo slancio cieco dell’onda mediatica che esaltava le magnifiche sorti e progressive del modello neoliberale e pretendeva piena, incondizionata fiducia in esse.
La classe capitalistica, la cui inettitudine viene continuamente messa in luce dalla letteratura sul “declino”, persevera nella sua autoreferenziale esaltazione della propria missione di classe dirigente, scaricando tutte la responsabilità del “declino” sulla politica.
Ma né gli uni né gli altri, né gli storici o gli analisti del “declino” né il padronato nel suo complesso s’interrogano se sia o meno il caso di rivedere il giudizio dato sui comportamenti antagonistici di classe degli Anni 70, anni di emancipazione e di produzione d’intelligenza operaia. Su quel ciclo di lotte continua invece a pendere il giudizio di condanna come un momento di follìa collettiva, d’insensatezza. Io credo che la lettura di quegli anni dovrebbe rivalutare come chiave interpretativa quella battuta di Mario Tronti, che tanto fece sorridere allora quando fu pronunciata, e cioé che “la lotta operaia impone lo sviluppo capitalistico”. La vicenda Fiat dal 1980 al 2002 è la controprova della giustezza di quella affermazione: là dove la lotta operaia tace, là dove il suo silenzio si fa prolungato, il capitalismo s’infogna in una crisi mortale. Sconfitti gli operai nell’ottobre 1980 e dopo ventidue anni di pace sociale, la Fiat e con essa l’industria italiana dell’auto, erano a terra.
1. Mi viene in mente questo tòpos della nostra storia recente quando osservo ciò che accade nel mondo della logistica. Qui possiamo addirittura parlare di un “modello italiano”, la cui premessa è la convinzione della grande impresa italiana che la logistica è un costo e non un’opportunità di creazione di valore. Dunque un costo che va compresso con l’esternalizzazione ed un continuo, ossessivo logoramento dei prezzi lungo la catena, mettendo anche in conto che il lavoro negli ultimi anelli possa raggiungere la condizione di schiavitù. Un modello tipico di una classe capitalistica che non investe e non innova, di un capitalismo orientato alla rendita, ai sussidi pubblici. Un capitalismo che oggi si trova all’appuntamento della digitalizzazione a dir poco impreparato, con un parco macchine obsoleto (quei pochi che hanno rinnovato hanno aspettato la legge Calenda per farlo). Un capitalismo integrato nelle reti globali solo presso una ristretta minoranza d’imprese, un capitalismo di devastante miniaturizzazione della dimensione d’impresa. In queste condizioni il salto tecnologico che la digitalizzazione impone, la cosiddetta Industria 4.0., può essere fatale e determinare il definitivo distacco dell’Italia dai paesi cosiddetti “avanzati”. Se attribuiamo pertanto alle lotte nella logistica il potere di costringere il capitalismo italiano a rivedere questo suo modello, se si comincia ad automatizzare operazioni che oggi vengono svolte manualmente, se si comincia a portare il salario contrattuale dei facchini allo stesso livello dei metalmeccanici (e tra poco ci siamo, se i metalmeccanici continuano a firmare contratti con aumenti salariali zero e scambi salario-welfare aziendale), chissà che lungo la catena, partendo dall’ultimo anello e risalendola, non si riesca a produrre quella onda d’urto, quell’evento traumatico in grado di risvegliare il Frankenstein dormiente?
Possiamo concederci quest’ultima utopia operaista?
2. Ho alcuni dubbi, per due ragioni. La prima è che le trasformazioni che avvengono nella logistica oggi sono determinate essenzialmente dall’e-commerce e quindi interessano la sfera del consumo, non quella della produzione, interessano mercati locali, abitudini urbane, non incidono sulle reti globali. In un documento recente di Deutsche Post, che controlla DHL, si diceva che due sono state le grandi rivoluzioni nella logistica: il container e l’e-commerce, il primo si appoggia sui trasporti a lunga distanza, il secondo sui trasporti a brevissima.
La seconda ragione per la quale mi sembra illusorio pensare che le lotte dei facchini, trasformando l’organizzazione del lavoro nella logistica, possano determinare un cambiamento di modello generale, è data dal fatto che esse non incidono sul vero, spaventoso, buco nero della nostra società capitalistica, e cioè sulla condizione del lavoro intellettuale. Prestigiose Fondazione culturali che richiedono per l’assunzione anche temporanea laurea magistrale e conoscenza di almeno due lingue straniere pagano anche cinque euro all’ora; le tariffe provinciali di riferimento dei facchini in area emiliano-romagnola si aggirano sui 20 euro all’ora. Ammesso che quelle di fatto siano anche la metà, risultano sempre il doppio del laureato con conoscenza di due lingue straniere. E qui entra in gioco un altro problema. La condizione di ricatto in cui si trovano di fatto molti di questi giovani e che la maggior parte subisce in silenzio non può più essere ridotta a una condizione di deficit sindacale, perché non si tratta più di mancanza di regole contrattuali, si tratta di una condizione d’inciviltà diffusa che non può non coinvolgere direttamente altre istituzioni oltre al sindacato e che appesta la qualità della vita in intere metropoli, dove i cosiddetti “talenti” della cosiddetta “classe creativa” di cui parlava il buon Florida sono umiliati, mortificati, soffocati proprio da quelle istituzioni che spesso vengono usate per produrre l’immagine splendente di una città. Dunque può (deve) intervenire anche l’ente locale, la rappresentanza della città. E’ questo il grande valore simbolico che assume l’iniziativa della Freelancers Union degli Stati Uniti con il Freelancers is’nt free Act, una legge locale del City Council di New York, entrata in vigore il 15 maggio 2017, in base alla quale il governo della città si fa parte attiva nel tutelare i diritti dei lavoratori indipendenti (contratto scritto, pagamenti tempestivi e integrali, protezione da rappresaglie e ritorsioni da parte del datore di lavoro/committente per chi denuncia le sue scorrettezze). Una città come Milano, che si vanta di essere all’avanguardia, proiettata verso un futuro 4.0., non può tollerare che giovani giornalisti vengano pagati 3 euro al pezzo, che assistenti a esposizioni d’arte vengano pagati 5 euro all’ora o che persone in ambiti culturali che riguardano la cura e la valorizzazione del patrimonio artistico nazionale prestino la loro opera gratuitamente. E questi non sono che miseri esempi di un fenomeno diffuso a macchia d’olio in tanti settori sia del lavoro intellettuale sia di quello tecnico-artigianale, che impiega tecnologie sofisticate e sistemi d’intelligenza artificiale.
3. Per affrontare il discorso sul lavoro intellettuale – me ne sono convinto sempre più in questi ultimi vent’anni che ragiono sul lavoro autonomo e partecipo alla sua emancipazione – bisogna lasciarsi alle spalle il paradigma operaista. Non solo è inutile, è dannoso. L’operaismo è figlio del fordismo, è la sua immagine rovesciata. Il paradigma operaista faceva perno sulla classe operaia, anzi, sulla lotta operaia. Il lavoro intellettuale e le sue aporie sono materia di borghesia. Lo stesso Marx non aiuta, i pochi riferimenti al lavoro astratto non sono sufficienti ad immaginare un percorso di antagonismo. Ci aiuta il ’68? In parte. Nella sua critica alle discipline e alle deontologie professionali, più che nella critica alle istituzioni, ci sono i germi di un discorso che si può sviluppare. Il paradigma operaista recuperava il lavoro intellettuale nella nuova classe dei tecnici, la nouvelle classe ouvrière la chiamava Mallet. I tecnici di manutenzione dell’Olivetti Elettronica, i tecnici di laboratorio della Snam Progetti…ricordate? Ma non è questo l’approccio che oggi ci serve per mettere a fuoco le contraddizioni del lavoro intellettuale. Ci aiuta il ‘77? In parte, la tematica dell’autovalorizzazione ha fatto fare dei passi avanti, ma spesso non ha prodotto altro che modi di vita “alternativi”, marginali, azioni da “esodo interno”.
Forse dovremmo partire dall’esodo di massa che oggi caratterizza i giovani italiani, in particolare laureati. Può essere visto – questo esodo – come il primo episodio di autonomia del lavoro intellettuale? Le comunità italiane all’estero, possono essere quelle il nostro riferimento? Quelli sono i figli diretti del “declino”. Dovremmo anche ragionare sulle sconfitte. Perché in Italia non si è consolidato un movimento dei precari? La mia risposta, lo sapete, è che quella precaria è una non-identità. Di quella sconfitta hanno approfittato i movimenti populisti e sovranisti per costruire un loro anticapitalismo no global. Noi continuiamo ad attardarci nell’analisi della composizione tecnica del lavoro postfordista, abbiamo sparso fiumi d’inchiostro sul bio-sfruttamento. Dobbiamo forse ricominciare da altre linee di partenza.
4. Prima di tutto si dovrebbe evitare l’errore di partire dall’intelligenza artificiale per discutere di lavoro intellettuale. Sarebbe un ritorno meccanico al paradigma operaista, ci porterebbe in un vicolo cieco (solita dinamica della sostituzione del lavoro con le macchine, paradigma troppo semplice per poter affrontare la complessità di quello che è stato chiamato con orrendo neologismo il “cognitariato”). Si dovrebbe invece passare al vaglio un po’ di concetti, per vedere se funzionano. Quello di “capitale umano”, per esempio. E’ una trappola, una buffonata? Oppure è una complessità da dipanare? Idem il concetto di professione. Se nelle teorie operaiste e nella storiografia operaia l’idea di mestiere ha svolto un ruolo così importante, perché non dovrebbe avere un ruolo altrettanto importante il concetto di professione? Abbiamo trascurato e spesso ignorato la sociologia delle professioni. Varrebbe forse la pena di approfondire. Di certo non possiamo trascurare il mutamento dell’agorà, la trasformazione della Oeffentlichkeit, cioè del luogo pubblico in cui si discute e si forma il linguaggio della comunicazione civile. Il ruolo dei social nella distruzione della mente, nella svalorizzazione della competenza. Riprendiamo in mano il binomio autorità-autorevolezza. La rivolta contro la soppressione della libertà di parola ha prodotto straordinarie opere d’ingegno, aver dato il microfono a tutti sta producendo instupidimento generale. Tra umiliazione del lavoro intellettuale e distruzione della mente noi dobbiamo trovare il varco per uscire dall’impasse, per riconquistare quel terreno dove possiamo ripiantare la storia militante, anche se per il primo tratto di strada dovessero essere i facchini a portarci sulle loro spalle.