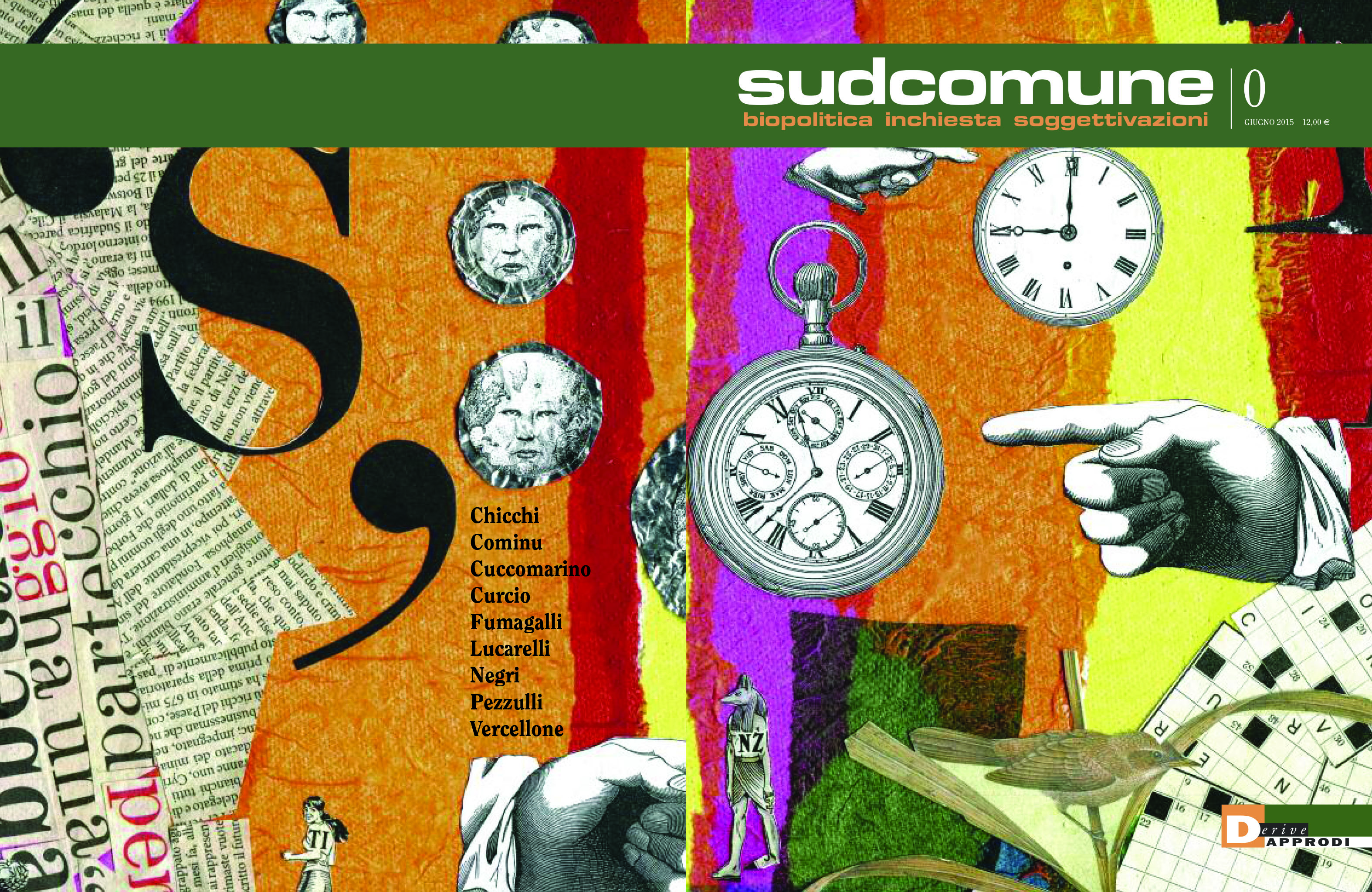di TONI NEGRI (in sudcomune, n.0/2015)
Il secolo XX° si è concluso, ma il tentativo imperiale di unificazione economica, culturale e militare del pianeta da parte degli Stati Uniti d’America non è riuscito. E’ fallito il tentativo imperiale di dare un senso lineare agli accadimenti, di imporre la regola economica prodotta da Wall Street ad una economia ora non più basata su flussi imperialistici – ma appunto imperiali. Il tentativo di costruire una nuova Roma, per fare un esempio antico, in grado di imporsi mondialmente, di diventare il riferimento centrale per la cultura occidentale, fondamentalmente anticomunista, liberale, non è riuscito. Cosi come non è riuscito ad imporsi neppure il modello che era stato affermato nel lungo periodo tra i due Bush, quello di un comando militare unico e unilaterale. Questo è uno dei grandi elementi della crisi oggi. Dopo la fine del socialismo, dell’Unione Sovietica con i suoi satelliti, il mondo è tornato ad essere caotico, però su nuove dimensioni, che non sono più quelle nazionali, ma essenzialmente globali. Oggi si tratta di sistemi monetari che si sono unificati attorno a poli regionali: l’America latina; la Cina, che è una grande regione e che tenta di annettersi la Corea e il Giappone; l’Europa, che tenta disperatamente di diventare un’unità regionale, il sistema indiano eccetera. Con il XXI° secolo insomma comincia a delinearsi una nuova figura capitalistica della quale non si colgono tutti gli aspetti, in cui l’unico elemento centrale ben visibile è la fine dell’unilateralismo del potere americano.
L’altro elemento centrale è la nuova forma del lavoro, le nuove modalità di lavorare. Quando si discute della fine della classe operaia ovviamente non si vuole dire che la classe operaia non esiste più. Assolutamente no, la classe operaia c’è ancora – eccome! – e lavora come lavoravano i nostri vecchi, in maniera seriale, taylorizzata. E vale ancora lo stesso modello di sfruttamento della vecchia classe operaia, accentuato nelle nuove forme che si sono date nei processi di sviluppo e accumulazione. Quelli che si sono modificati sono i processi di valorizzazione del lavoro. Cosa vuol dire? Vuole dire che il lavoro industriale è diventato quantitativamente inferiore al lavoro “post industriale”, e che questo lavoro postindustriale rappresenta, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, la sostanza dei processi di valorizzazione, ossia dei processi che danno valore alle merci. Il contenuto di questi processi di valorizzazione è ora l’intellettualità, è l’invenzione, è il lavoro cognitivo, è il lavoro che determina relazioni, che produce linguaggi e codici, che forma idee; e che come tale, come lavoro cognitivo, penetra le merci e gli dà valore. Questo non significa che sia finito il lavoro materiale, ma che anche il lavoro immateriale è sottoposto a forme di disciplina e di sfruttamento che somigliano molto da vicino a quelle del lavoro materiale: tra la Fiat Mirafiori del 1950 ed un call center di oggi esistono pochissime differenze dal punto di vista della disciplina, mentre ne esistono enormemente dal punto di visto del lavoro che viene valorizzato. Nel primo caso era lavoro fisico, nel secondo è lavoro mentale.
Quando si dice che la classe operaia viene meno nei processi produttivi si dice semplicemente che il lavoro è oggi organizzato attraverso le attività cognitive. Questo significa tante cose: innanzitutto che abbiamo a che fare con un lavoro “mobile”, che non ha più bisogno di essere chiuso in una fabbrica, che invece attraversa le frontiere e si situa nei grandi flussi di comunicazione; e poi che è divenuto un lavoro “flessibile”, un lavoro che ha rotto le caratteristiche massificate del lavoro industriale. Ognuno di noi possiede il suo computer e attraverso il computer si mette in relazione, forma strutture lavorative. Ciò può dirsi per tutti i media sociali, che prima di essere ogni altra cosa sono strumenti di lavoro. In secondo luogo, questa mobilità traversa e mette in relazione tutto il lavoro possibile nel globo, è un lavoro che attraversa le frontiere e si collega con tutti i movimenti della forza lavoro. Quello che è importante in questo tipo di lavoro è la porzione di intelligenza che ogni singolarità mette in produzione; il valore non si crea più semplicemente attraverso massificazione, cioè l’accumulo di unità simili o identiche come si faceva nell’industria tradizionale, dove si costruivano tanti pezzi e si mettevano assieme. Oggi il valore viene fuori da invenzioni specifiche, singolari, ma queste singolarità racchiudono le caratteristiche della “classe” – una classe diventata moltitudine. È la vecchia classe operaia, produttiva, che è trasmutata in moltitudine di singolarità. Singolarità non significa individuo, l’individuo è qualcosa che sta lì, con la sua anima che risponde al buon dio, con la sua sostanza metafisica che lo chiude in se stesso. No, il capitalismo ha avuto se non altro l’enorme funzione di distruggere le identità, e di mettere la nostra testa a disposizione dei linguaggi; ognuno di noi è il prodotto di una serie di linguaggi, di una serie condizioni che creano singolarità; e questa singolarità può essere aperta in maniera innovativa, bella, ricca, generosa, all’interno di una comunità, di un comune. Teniamo quindi presente che il comune non è qualcosa che ci precede, è qualcosa che costruiamo.
Questa modificazione radicale del lavoro investe le soggettività al lavoro perché la produzione e la valorizzazione passano attraverso una moltitudine di lavoratori mobili nello spazio e flessibili nel tempo, essenzialmente singolari. La vecchia classe operaia era immobile nello spazio. Una volta si diceva, non per gioco, che Torino era una città immobile, che i tram circolavano all’ora di entrata e uscita dalla fabbrica, alle sei, alle due del pomeriggio ed alle dieci di sera; il ritmo delle “tre otto”, otto ore di lavoro, otto ore di sonno e otto ore di socialità, era il ritmo della vita. Va aggiunto che era una gran fregatura, perché di queste otto ore di socialità ne spendevi magari due all’andata in fabbrica e due al ritorno, cosicché te ne restavano quattro, durante le quali dovevi accompagnare i bambini a scuola e fare dell’altro. Non a caso il rifiuto del lavoro, questa grande pratica dell’operaio massa, consisteva nel rifiuto dei “tre otto”. Mi scappa da ridere quando sento questi che vorrebbero tornare a quella epoca, perché i “tre otto” erano in realtà una forma di tortura che il lavoratore subiva.
Dunque, oggi, abbiamo un nuovo tipo di classe operaia. Quando con Michael Hardt e molti altri compagni abbiamo cominciato a parlare di queste cose, dopo la fine dell’89, ci prendevano per matti. Noi eravamo esuli in Francia, ed avevamo costruito a Parigi un grosso centro di ricerca attorno a delle riviste (“Futur Anterieur”, “Multitudes”) e attorno a dei centri universitari (“Paris VIII”, “College International de Philosophie”). In un primo momento ci leccammo le ferite, ovviamente, perché avevamo fatto, con gli operai, le lotte degli anni ’60 e gli anni ’70 ed eravamo stati sconfitti. Sconfitti pesantemente. Poi però, come sempre succede quando si fa lotta di classe (cosi come in ogni altro momento di vita e di amore) abbiamo ripreso a studiare, a riprenderci la vita, la lotta, la speranza: alla sconfitta occorreva reagire, e in molti reagimmo. Si trattava di riaprire la riflessione e la discussione sul metodo e la sostanza del nostro pensiero. Non fu un lavoro superficiale. Abbiamo allora cercato di rinnovare l’analisi dell’imperialismo e quella della sovranità, ci siamo occupati di analizzare il destino dello Stato sovrano, quello del capitale sovrano, di fronte a quello che stava succedendo. Impero è in qualche modo il riassunto dei quattordici anni passati in esilio in Francia, da vari punti di vista: è analisi della crisi del pensiero occidentale legato alla modernità e, da un’altra angolazione, analisi della trasformazione del lavoro e quindi della trasformazione delle strutture di controllo sociali.
Ora le trasformazioni del lavoro e dei processi di valorizzazione, ai quali abbiamo accennato, sono alla base dell’attuale crisi economica. Dal 2008, ma probabilmente anche da prima, è infatti in atto il tentativo di riorganizzazione dello sviluppo capitalistico a partire dalle trasformazioni del lavoro e dei processi di valorizzazione che si sono dati. Molti analisti hanno parlato di un nuovo processo di accumulazione originaria. Marx nel Capitale, quando parla della genesi del capitalismo, parla di accumulazione originaria. L’accumulazione originaria consiste in una serie di operazioni socio-politiche che il capitale compie per costruire nuove condizioni della produzione, rappresentate allora dalla produzione industriale. Si strappano contadini alla campagna attraverso la privatizzazione di quelli che erano allora i commons, o beni comuni, cioè le foreste, i pascoli, eccetera. Si privatizzano queste determinanti della riproduzione delle popolazioni che così vengono spinte dalla pressione economica (dalla miseria) verso i centri di produzione. Questo processo non è stato soltanto un processo di reclutamento della forza lavoro, ma anche un processo di appropriazione di capacità umane: dentro il reclutamento vengono infatti prescelte, raccolte, unificate e messe in produzione le capacità artigianali, le attività produttive preindustriali, ora inserite in nuovi sistemi di produzione, centralizzati e comandati in maniera gerarchica attraverso stratificazioni sociali e forme del comando estremamente rigide. Tutto questo costituisce il sistema della fabbrica moderna. Oggi, il nuovo processo di produzione da forza cognitiva attraversa esso stesso una accumulazione primitiva. Un’accumulazione del tutto originale, perché ora espropria il comune, non semplicemente i commons naturali ma anche quelli storicamente prodotti, le esternalità positive, l’atmosfera e la vita e lì si riorganizza in un rapporto di sfruttamento assoluto. L’accumulazione originaria si propone ora come appropriazione capitalistica del comune, quando nel comune si compongano quelle qualità superiori della produzione, realizzate dal lavoro cognitivo, nella comunicazione, nei servizi, nella circolazione e nello scambio dei rapporti vitali.
Gli anni ’70 sono caratterizzati da tante cose, ma da due in particolare. Dal punto di vista industriale, sono caratterizzati dall’automazione nelle grandi fabbriche, cioè dal fatto che si buttano fuori gli operai perché si automatizza la produzione. Il secondo processo è quello dell’informatizzazione del sociale, che comincia in forme molto arretrate, per perfezionarsi progressivamente: in altre parole, informatizzazione sociale significa buttar fuori la gente dalla fabbrica imponendogli di lavorare nel sociale per la fabbrica. E’ cosi che la fabbrica comincia ad occupare il sociale. In questa situazione, nasce la tematica dell’operaio sociale, un operaio diffuso nelle fabbrichette, nelle cantine delle case, dove le famiglie sono messe al lavoro da quel genitore che era stato buttato fuori dalla fabbrica. Poi l’informatizzazione comincia a diventare molto più estesa ed importante rispetto a questi inizi. Attraverso l’informatizzazione si ha la diffusione produttiva, la “fabbrica diffusa”, in cui il secondo termine, la diffusione, diventa più importante del primo, la fabbrica, perché la produzione viene ormai organizzata attraverso un sistema di servizi produttivi.
La produzione non si fa più puntualmente; la nuova valorizzazione nasce nella circolazione. Quindi, anche gli schemi marxiani vanno probabilmente modificati. Non ci sono più semplicemente “produzione”, “riproduzione”, “circolazione”. C’è una circolazione che interviene direttamente nella produzione e in questo modo genera un enorme aumento della produttività perché riassume la potenza sociale del produrre. Allo stesso tempo è un rapporto che diventa molto complicato, che si modifica, perché l’operaio oggi, cioè colui che esprime un’attività produttiva, ha recuperato una parte di “capitale fisso”. Secondo la lettura marxiana, il capitale è formato da “capitale costante” e “capitale variabile”, da un “capitale fisso” e un “capitale circolante”. Il capitale costante è il padrone con tutto il suo denaro, i suoi mezzi di produzione; il capitale variabile è il denaro che viene pagato per i salari, è la figura collettiva del lavoratore; il capitale fisso è l’insieme dei mezzi di produzione (materie prime, eccetera), che comprende anche il know how che una volta era di proprietà della capacità manageriale; il capitale circolante è quello che vive nella circolazione. Oggi tutte queste forme di capitale sono confuse, perché gli operai, con la loro conoscenza, si sono appropriati di parte del capitale fisso, e quindi fanno circolare il loro sapere, i loro linguaggi nella produzione. Il capitale cognitivo non è un capitale raro, che si spende immediatamente nella produzione, come una materia prima. Non è cosi, anzi quanto più lavori dentro i progetti cognitivi, tanto più diventi intelligente e capace di dominare i progetti stessi. Il cervello è infatti una pianta che cresce soprattutto quando è nutrita dalla relazione con gli altri cervelli. Oggi la socialità del lavoro, la cooperazione del lavoro, sono diventati elementi costitutivi fondamentali del valore, non siamo più dinnanzi a lavoro vivo che viene strappato ma – nello strappo, nell’estrazione – lavoro vivo che interviene in maniera attiva nei processi produttivi. Tutto ciò fa sì che il capitale si faccia capitale finanziario per innalzarsi sopra questa realtà vivente del lavoro e della produzione; e la forma di comando che viene esercitata su questo lavoro è una forma di comando che non passa oggi attraverso il vecchio imprenditore che spesso era stato operaio come gli altri, e poi si era posizionato un momento più sopra, mostrando capacità di organizzare la fabbrica. Non è nemmeno l’imprenditore classico schumpeteriano. È un imprenditore che nasce già finanziario: sono le banche i veri imprenditori. È l’investimento bancario che determina l’organizzazione del lavoro, quel tanto di organizzazione del lavoro che il capitalista ancora fa. Perciò la capacità di comando sul lavoro, quando il lavoro è diventato cosi potente, si stacca dalla produzione. Ciò non significa che il capitale finanziario sia solo una cosa nemica. È nemica perché è capitale, ma costruisce un insieme razionale della produzione globale. I lavoratori devono riappropriarsi della struttura finanziaria, perché ormai senza questa struttura finanziaria non si produce. E senza riappropriarsi di questa struttura finanziaria l’operaio non può guadagnarsi il mondo.
Siamo in una situazione in cui tutto è cambiato e non si può ripetere il discorso banale che la finanza è una cosa orribile che sta sopra le nostre teste. Certo, è anche questo. Ma la finanza è rappresenta oggi il capitale, e quindi rappresenta oggi quel rapporto sociale un tempo stabilito dal semplice rapporto tra il capitalista ed il singolo lavoratore o la massa dei lavoratori.
La crisi non rappresenta dunque il distacco tra finanza e produzione “reale”, la finanziarizzazione non è parassitaria di quote crescenti di plusvalore, o di risparmio collettivo, ma è la stessa forma in cui l’accumulazione di capitale oggi si realizza ed è una forma di accumulazione totalmente simmetrica, corrispondente, ai nuovi processi di produzione sociale e cognitiva.
Oggi il capitale finanziario è quella parte del nostro mondo che si oppone alla moltitudine delle singolarità lavoratrici ed è questo il rapporto nel quale oggi viviamo e sul quale si sviluppa la lotta di classe, non più semplicemente al livello dei singoli paesi ma sulla faccia della terra. Ed è a questa dimensione che si aprono tutti i problemi politici e strategici che è necessario porsi.
Che cos’è il comune? C’è un comune che sia chiama terra, aria e altre cose naturali, quello che una volta si chiamava commons o beni comuni, che però sono difficilmente definibili da un punto di vista puramente naturalistico. L’aria, per esempio, sappiamo bene cos’è, ma poi nell’aria ci sono tutti i prodotti dell’inquinamento, è qualcosa che purtroppo è già manipolata. Per l’acqua, invece, abbiamo votato i referendum, il 90% ha votato per avere acqua non privatizzata, ma poi abbiamo scoperto che l’acqua nelle nostre mani non significa nulla, che la struttura del capitale è organizzata intorno alla manipolazione ed al possesso dell’acqua, dell’accesso a questo bene comune. Insomma, quando parliamo di comune in termini naturalistici dobbiamo stare molto attenti perché quello che è comune in termini naturalistici è qualche cosa che è già stato in qualche modo assorbito e riespresso dal lavoro umano; la natura ormai difficilmente può essere “disinvestita”, difficilmente può essere tolto alla natura l’investimento che l’uomo ne ha fatto. La natura non è più qualcosa che ci è dato, ma qualcosa che ci è stato dato e che è stato trasformato. Il concetto di comune naturale è svuotato della sua essenza originaria, mentre c’è un comune che invece ha una sua forza effettiva: sono i linguaggi, i codici, i costumi, e soprattutto il lavoro, che è stato socializzato e posto come base di ogni ricchezza. Il lavoro è un comune dal punto di vista stesso della sua genealogia, perché oggi non si riesce a produrre se non in maniera cooperativa, ogni cosa che è umana diviene immediatamente comune in quanto prodotto della nostra intelligenza e della cooperazione e però oggi il capitale domina il comune.
In conclusione, abbiamo un padrone che si chiama finanza e abbiamo un lavoro che si chiama azione produttiva, sociale, cooperativa, cognitiva ed è su questo terreno che la crisi non è un blocco della produttività ma è un tentativo della finanza di piegare in modo assolutamente determinato la nuova figura del lavoro alla sua riorganizzazione.
Intervento al seminario Crisi globale e costituzione del comune, organizzato dal collettivo Euronomade e dal Laboratorio Sancho Panza, presso il Centro di promozione sociale e culturale di Ferrara “La Resistenza”, il 14 maggio 2013.