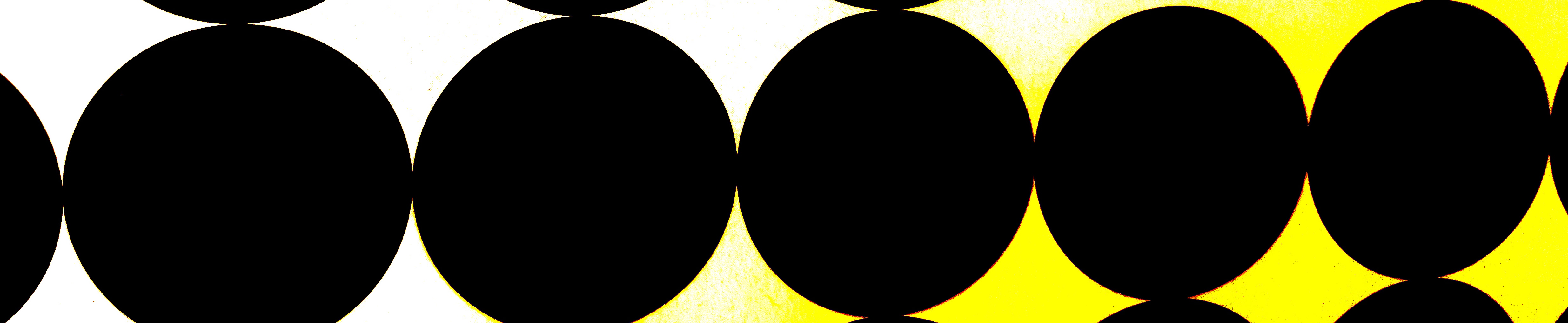di PIETRO BIANCHI (in doppiozero.com, settembre 2017)
A Greensboro, in North Carolina, l’1 febbraio 1960, quattro studenti del primo anno della North Carolina A&T State University – Joseph McNeil, Franklin McCain, Ezell Blair Jr., e David Richmond – entrano in un cosiddetto five and dime store di Woolworth (un’azienda che oggi conosciamo con il nome di Footlocker), uno di quei negozi che vendevano vari prodotti per la casa scontati a pochi centesimi. Comprano un dentifricio e altre piccole cose, vanno alla cassa, li pagano e poi si avvicinano al lunch counter del negozio per ordinare un caffè. Quel caffè però non gli verrà mai servito perché contrariamente al resto del negozio, i lunch counter di Woolworth, così come accadeva in molti altri negozi nel Sud degli Stati Uniti, erano “white only”, rifiutavano cioè il servizio alle persone di colore. Il manager chiede allora ai quattro ragazzi di andarsene ma quelli che poi verranno soprannominati come gli A&T Four decidono invece di fare un’azione eclatante: rimangono nel negozio fino alla chiusura. Il giorno dopo accade lo stesso, questa volta però ai quattro ragazzi si uniscono decine di altri studenti di colore di altre università della zona che danno vita a quella che diventò una delle più importanti iniziative politiche del Civil Rights Movement.
Spesso si racconta che il gesto degli A&T Four fu un gesto spontaneo di protesta, perché l’ideologia dominante chiama così le forme di protesta che non riesce a comprendere. La cosiddetta “spontaneità” sarebbe un segno di improvvisazione, casualità, a volte persino di ingenuità. Si tratta in realtà di un giudizio che vorrebbe ridurre questi eventi di resistenza a una natura pre-politica, episodica, e dire che così come sono venuti fuori dal nulla sono inevitabilmente destinati a ritornare nel nulla. La realtà però è molto diversa e Jacques Rancière ce l’ha spesso ricordato: atti di resistenza, d’insurrezione e di rivolta avvengono in realtà ovunque e in ogni momento. Il problema è che spesso la sensibilità del potere non è capace – per motivi strutturali – di riconoscerli e quindi finisce per ridurli a crimini comuni o relegarli a espressioni marginali di malfunzionamento del sistema.
Michael Hardt e Toni Negri direbbero invece che gli eventi di Greensboro lungi dall’essere una forma “spontanea” di protesta, mostrano tutta l’intelligenza sofisticata e strategica della moltitudine. Il Civil Rights Movement, così com’è avvenuto con mille altri movimenti di emancipazione nella storia, non nasce “spontaneamente” ma viene preparato e organizzato collettivamente anche senza la presenza di un partito o di un leader che se ne metta a capo. Per dirla con uno slogan che ormai è diventato celebre: non è stato Martin Luther King a creare il Civil Rights Movement, è stato il Civil Rights Movement che ha creato Martin Luther King.
In Assembly (Oxford University Press, 336 pp., £ 25) – il loro ultimo libro uscito negli Stati Uniti in questi giorni, che va a comporre ormai una tetralogia di grande successo nel pensiero critico degli ultimi anni insieme a Empire (Harvard University Press, 2000), Multitude (Penguin, 2004) e Commonwealth (Harvard University Press, 2009) – Hardt e Negri provano a riflettere sulle modalità contemporanee di auto-organizzazione dei movimenti e sulle loro enormi potenzialità prendendo di petto una delle congiunture politiche più delicate degli ultimi anni. A partire dalla crisi del 2008 si è infatti avuta una risposta neoliberista che è stata, se possibile, ancora più feroce rispetto a quella dei due decenni precedenti: dal ritorno dei governi conservatori in Sudamerica dopo quindici anni di laboratori di sinistra all’offensiva ordoliberale a trazione tedesca dell’Unione Europea, dal governo reazionario di Modi in India al capitalismo autoritario di Erdoğan e di Putin, non si può certo dire che l’equilibrio dei rapporti sociali in questo momento penda dalla parte delle classi lavoratrici. E tuttavia è anche vero che questi sono stati gli anni di Gezi Park e di Occupy Wall Street, delle primavere arabe e di innumerevoli lotte sui beni comuni (come a Standing Rock in North Dakota), degli Indignados in Spagna così come di Black Lives Matter negli Stati Uniti. L’operazione del libro è allora quella di gettare uno sguardo non tanto sulle insufficienze di questi movimenti quanto sul loro dato di innovazione politica e di radicalismo delle forme di lotta. E di chiedersi, posizionando il proprio sguardo all’interno di queste esperienze, come sia possibile che un movimento possa durare nel tempo e creare una trasformazione sociale duratura.
Assembly si colloca infatti anche nel momento della crisi di molte delle risposte delle istituzioni della sinistra alla crisi economica. È un libro cioè che si colloca dopo l’enorme delusione che hanno prodotto le due presidenze di Obama così come dopo la catastrofe di Syriza e lo squagliamento di ogni possibile opzioni social-democratica in Europa: in un momento dove anche l’azione sindacale sta incontrando moltissime difficoltà in molti paesi del mondo occidentale e dove persino le migliori sperimentazioni della sinistra istituzionale come Podemos paiono subire una battuta d’arresto. È paradossale infatti che in un momento in cui il capitalismo sta attraversando una storica crisi di profittabilità a cui è in grado di rispondere soltanto attraverso un enorme dispositivo di finanziarizzazione e di creazione di bolle speculative, e tramite disoccupazione, deindustrializzazione e svalutazione di capitale, non si sia riusciti a dare una risposta autenticamente anti-capitalista che vada a sinistra.
La tesi di Hardt e Negri, che non manca certo di un tono apertamente provocatorio, è che sia necessario oggi andare nella direzione di un’innovazione radicale di molte di quelle che sono state le pratiche e le forme tradizionali della sinistra politica. E la cosa naturalmente è tanto più urgente quanto più vediamo diventare egemoni a sinistra sia posizioni neo-sovraniste che cantano le lodi della resistenza degli stati nazione alla globalizzazione neo-liberista (con accenni che più che nazionalisti sono ormai apertamente razzisti) sia ipotesi del tipo Comité Invisible in Francia o Endnotes negli Stati Uniti fondate o sull’estemporaneità del riot o sulla visione secondo la quale la caduta della profittabilità del lavoro e l’automazione porteranno di per sé a un aumento dell’entropia sociale.
Esattamente come in North Carolina nel 1960 allora, secondo Hardt e Negri i movimenti delle piazze di questi anni non hanno avuto nulla di spontaneo o estemporaneo ma sono semmai l’esempio di una sopraggiunta maturità politica: anzi il fatto che siano comparsi nello stesso momento a diverse latitudini dal Brasile all’Egitto, dalla Spagna agli Stati Uniti, dal Kurdistan alla Grecia, mostra come la loro natura non sia nient’affatto episodica ma strutturale. Il fatto ad esempio che molti di questi movimenti non abbiano espresso alcun leader “mediatizzabile” non riguarda un loro presunto scarso realismo politico ma dipende dal fatto che come ha fatto Black Lives Matter, fossero in grado di produrre una propria consapevole e assai meditata critica del dispositivo di creazione di leader, anche per come si è data nella storia dei movimenti. Hardt e Negri ribaltano l’idea secondo cui il sociale manchi di strategia sul lungo periodo preso com’è da interessi particolari e da questioni contingenti e proprio per questo necessiti di un leader che sappia “guardare lontano”: il rapporto tra tattica e strategia andrebbe rovesciato perché è la strategia (di lunga durata) che apparterebbe ai movimenti mentre una prerogativa tattica occasionale, parziale e variabile dovrebbe essere concessa solo provvisoriamente a dei leader sempre revocabili.
Il problema tuttavia rimane il rapporto con il potere e con la sproporzione della sua forza nel momento in cui i movimenti incontrano la violenza delle politiche repressive (lo smantellamento della sinistra politica turca dopo Gezi Park è solo uno degli innumerevoli esempi).
È lo stesso enigma che ha attraversato i comunardi parigini nel momento in cui hanno dovuto scegliere tra la fedeltà al loro radicalismo democratico e assembleare – contro cui si sarebbe scagliata inevitabilmente la violenza dello stato – e una forse più consigliabile via moderata più vicina al modello della rappresentanza liberale. La soluzione, dal sapore insolitamente quasi benjaminiano degli autori, è che è stato proprio “l’errore” dei comunardi a dimostrarsi giusto ora a distanza di quasi due secoli laddove i limiti della rappresentanza liberale sarebbero ormai sotto gli occhi di tutti. Se per i cantori della restaurazione dell’epoca quell’esperimento ha peccato di estremismo, è soltanto oggi che ne vediamo la vera lezione di grande realismo politico.
Ma come è possibile allora relazionarsi con il potere, che oggi ha il volto del neoliberismo finanziario, senza sottostare a quel monopolio della decisione su cui da sempre si è basato il modello della sovranità e senza tradire lo spirito dell’orizzontalità assembleare? Come è possibile per un movimento pensare di trasformare i rapporti sociali esistenti senza mettere al centro l’occupazione dell’apparato statale? Innanzitutto. per Negri e Hardt, attraverso l’invenzione di istituzioni in discontinuità con la tradizione moderna, come viene fatto nelle lotte del Rojava che ha da tempo abbandonato l’idea di creare un nuovo stato sovrano. Ma in Assembly la creazione di un nuovo istituzionalismo deve andare persino più lontano perché non risiede tanto nella sfera politica (durissime sono le parole sull’autonomia del politico) quanto nelle reti cooperative che animano la produzione e la riproduzione della vita sociale perché ridefinire la decisione politica senza mettere in discussione le fonti sociali ed economiche della diseguaglianza e della mancanza di libertà, compreso il ruolo della proprietà e del comando sulla produzione, non potrà mai essere abbastanza.
L’assembly del titolo infatti ha un doppio senso: non si riferisce soltanto agli assembramenti “di piazza” di Piazza Tahrir o Zuccotti Park ma anche a una dimensione più apertamente produttiva in senso economico. Assembly in inglese si usa anche per definire l’assembly line, la catena di montaggio delle industrie manifatturiere, che secondo Negri e Hardt avrebbero oggi lasciato il posto a una produzione post-industriale diffusa e reticolare, che si esprime sul terreno della produzione di soggettività prima ancora che di merci. I movimenti delle piazze esprimerebbero cioè l’essenza di un modello produttivo cooperativo e socializzato le cui assembly line sono le reti orizzontali della cooperazione sociale o persino quelle algoritmiche e digitali della rivoluzione informatica. L’innovazione di questi movimenti e il loro radicalismo democratico e assembleare avrebbero cioè un corrispettivo diretto in un modo di produzione che ne ricalca l’orizzontalità e per certi versi anche il modello decisionale de-centrato e democratico. È questa una tesi ampiamente nota di Negri e Hardt che risale quanto meno al Lavoro di Dioniso del 1995 ma che Negri sviluppò già negli anni Settanta e Ottanta: l’idea cioè che i processi di produzione di valore nel capitalismo contemporaneo siano ormai divenuti sempre più passivi e che si siano ridotti a mettere a valore un processo di produzione che pre-esiste il comando capitalistico e che si organizza autonomamente (non è un caso che in Assembly il termine di “estrazione” di valore sostituisca quella di produzione, proprio per sottolinearne l’aspetto passivo). Il lavoro si auto-organizzerebbe tendenzialmente in modo sempre più autonomo nella cooperazione sociale e il rapporto capitalistico si strutturerebbe sempre più spesso come un rapporto non tanto di comando organizzativo quanto di vera e propria rapina ed espropriazione.
C’è naturalmente una parte di verità in tutto questo: la produzione è in effetti sempre più socializzata grazie alle reti informatiche e a un boom della logistica che ha permesso di integrare (anche se a seguito di un processo di frammentazione a volte assai traumatico) luoghi della produzione anche molto lontani tra loro all’interno di una medesima catena del valore. Quella che viene definita Industria 4.0 presenta effettivamente un’ampia gamma di processi lavorativi che vengono organizzati tramite reti informatiche e dispositivi di comando a volte molto “immateriali” lungo filiere spesso lunghe e opache. Eppure ci pare che il grado di autonomia di questo processo produttivo – anche a fronte di un’organizzazione più orizzontale e persino algoritmica – si mostri più come una questione politica aperta che come una soluzione già data. E se è vero che è l’intera società che partecipa a un processo di produzione di valore anche tramite il lavoro riproduttivo e di cura, è vero che non mancano forme di sfruttamento assai brutali anche a fronte di processi organizzativi più orizzontali e meno verticali che necessitano di una mediazione politica la cui forma e le cui modalità sono tuttavia tutte da ripensare.
Sulla scorta di Machiavelli, Negri e Hardt concludono il libro attraverso il richiamo a un “nuovo Principe”, cioè a una nuova struttura organizzativa della moltitudine che ne debba ricalcare la natura orizzontale e cooperante. Inventare istituzioni dal basso, così come inventare pratiche autonome di produzione e riproduzione sociale diventano due facce della stessa medaglia, secondo il principio di un’indistinzione sempre più marcata tra strategia politica e reti della produzione, tra lavoro e forme della soggettività, tra assemblearismo democratico e organizzazione della cooperazione sociale. Usando un termine deleuziano si potrebbe dire che l’assembly delle piazze e delle reti della cooperazione del lavoro ponga un problema di “assemblaggi”: l’enigma a un tempo politico ed economico è quello di trovare un modo per dargli una forma.